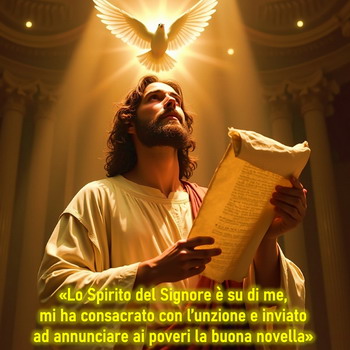«Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione» (v. 1a). Il testo richiama Is 42,1-7; cfr. Is 11,2, con la grande differenza che qui il profeta precisa che l’unzione gli è stata conferita dallo Spirito del Signore ed essa gli assegna la dignità regale, messianica. La menzione dello Spirito indica, inoltre, come questa missione ha origini e garanzie divine. Soltanto Dio può ridare vita a un popolo scoraggiato, aprendo orizzonti di speranza. Come si può notare in questo testo, il terzo Isaia parla della sua missione come compito giubilare che ristabilisce la fraternità, che è il sogno di Dio sulla creatura umana, fin dalla sua creazione e le restituisce la libertà che le aveva donato quando li liberò dall’Egitto.
Il compito dell’inviato dallo Spirito ha diverse componenti: – mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri;
– a fasciare le piaghe dei cuori spezzati;
– a proclamare la libertà degli schiavi;
– la scarcerazione dei prigionieri;
– promulgare l’anno di grazia del Signore (cfr. 61,1-2a).
Il lieto annuncio ai miseri
Il primo compito è «portare un lieto annunzio» ai rimpatriati che vivono situazioni simili a quelli quando erano in esilio. Anche il Deutero-Isaia aveva parlato ai Giudei esiliati in Babilonia del lieto annunzio del ritorno (cfr. Is 40,9; 41,27; 52,7). Tuttavia questo profeta postesilico parla non agli esiliati ma ai «poveri» o miseri che sono ritornati in patria e sono sfiduciati.
Il termine anawîm (povero, misero) nel libro di Isaia non è molto frequente, ma lo è in altri testi biblici, in particolare nella letteratura sapienziale, soprattutto nei Salmi.
Il termine povero o misero contraddistingue le persone che vivono nella sofferenza sia fisica che morale; le persone sfiduciate e oppresse, ma indica anche il mendicante.
Possiamo immaginare queste persone come “curve” perché sotto il peso di un’ingiustizia, di una malattia, di una sventura immotivata.
Il termine povero o misero indica anche la sofferenza dell’ingiustizia causata da un fratello che sfrutta e indebita economicamente un altro fratello. Questi miseri trasformano la loro angoscia in grido e cercano la vicinanza del Signore.
Ed ancora: in altri testi biblici il “povero” non è semplicemente il contrario del ricco ma la persona giusta secondo Dio, colui che rifiuta la violenza e ripone la sua speranza in Dio, che ascolta, appunto, il grido del povero (cfr. Sal 34,7; 86,1; 12,5). Alle persone che vivono queste situazioni dolorose, Dio risponde con un annuncio di gioia, che trasforma il tempo doloroso in un “anno di grazia”. Un effetto positivo di questo annuncio è rivolto a chi ha il cuore spezzato, viene infatti a «fasciare le piaghe dei cuori spezzati», viene a ridonare coraggio alle persone deluse, depresse, emarginate, senza alcuna speranza. Le persone i cui cuori sono spezzati, in realtà, sono quelle persone le cui speranze sono state infrante e le piaghe sono nei loro cuori più che nel corpo. Perciò sono piaghe difficilmente curabili se Dio non interviene.
Dicendo che viene a proclamare la libertà agli schiavi, sembra riferirsi a coloro che erano divenuti tali per debito, a causa della bramosia di altri membri del popolo!
L’anno di grazia del Signore
Il profeta, dopo aver proclamato questo lieto annuncio, proclama «l’anno di grazia per il Signore». Il termine grazia indica lo sguardo favorevole di chi è potente, come il re (Pr 14,35) o Dio (Dt 33,16; Is 49,8) verso la persona umile, povera, bisognosa.
L’anno di grazia nella tradizione biblica si riferisce all’anno giubilare (cfr. Lv 25,8-17; Dt 15,1-18), cioè all’anno del ritorno alla giustizia originaria e alla solidarietà fraterna. I profeti muovono critiche radicali a chi si è arricchito a scapito dei poveri. Il profeta Amos afferma che i poveri che hanno perduto la loro terra e quelli che per sopravvivere hanno dovuto vendere se stessi sono esempi di violenza iniqua che Dio non sopporta (Am 2,7). Essa nega, persino, il significato dell’esodo la cui liberazione, operata da Dio nei confronti dall’Egitto, aveva reso tutti fratelli di pari dignità, obbligandoli a vivere nella solidarietà reciproca. Il profeta Michea denuncia: «Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l’uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità» (Mi 2,2).
Ai tempi dell’esodo l’ingiustizia era praticata dagli Egiziani, ma ora dal popolo stesso di Dio verso i connazionali. Nell’anno giubilare vi sarà la remissione di tutti i debiti economici e la liberazione da ogni forma di schiavitù.
Il giubileo o “anno di grazia” acquista il valore simbolico di una nuova partenza, non più da un paese straniero che sia l’Egitto o Babilonia, ma da una situazione di ingiustizia sociale, che oscurando le grandi speranze del ritorno, eclissava l’identità del popolo, costituito da Dio per essere il popolo che vive l’Alleanza e canta le sue lodi.
L’orientamento sociale attribuito all’anno di grazia si comprende, proprio, sullo sfondo delle ingiustizie sociali, sorte tra i rimpatriati. (cfr. Lv 25,35-3; Ne 5,1-13). L’inviato di Dio dovrà eliminare le ingiustizie e le differenze sociali che creano discriminazioni (cfr. 58,6-7.10), per realizzare una comunità degna del suo Dio. All’anno di grazia corrisponde un “giorno di retribuzione /vendetta”: «il giorno di vendetta del nostro Dio» (cfr. 61,2b). La realizzazione del piano di salvezza del Signore richiede la punizione degli oppressori. Poiché la vendetta annunciata è in parallelo con la consolazione degli afflitti: «il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti gli afflitti» (Is 61,2). Possiamo intendere che questa vendetta riguarda i connazionali che praticavano l’ingiustizia, di cui Dio negli oracoli profetici di Isaia manifestava grande ribrezzo (cfr. Is 1,13-14).
L’anno di grazia proclamato da Gesù
Gesù inaugura la sua predicazione a Nazareth, leggendo Isaia 61,1-2a che richiama Is 58,6: «Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?». Del passo di Isaia 61, 1-2, Luca elimina il versetto 2b che parla di vendetta. Tacendo il riferimento alla vendetta (Is 61,2b), Luca evidenzia che la missione di Gesù è opera di salvezza e misericordia. Gesù, poi, nell’attribuire a se stesso la profezia di Isaia, dichiara che l’anno di grazia si compie nel momento stesso in cui Egli legge il testo sacro, ma a condizione che gli uditori e lettori di ogni tempo accolgano nell’ascolto della Parola, la sua Persona. È lecito domandarsi: è stato mai realizzato l’ideale del Giubileo?
Gli Atti degli Apostoli presentano la prima comunità cristiana come comunità giubilare: «Tra i credenti, nessuno era nel bisogno. Poiché tutti coloro che possedevano delle terre o delle case le vendevano, portavano l’importo della vendita e lo ponevano ai piedi degli apostoli. Si distribuiva allora a ciascuno secondo le sue necessità» (At 4,34-35; cfr. At 2,42-48). Questo testo sembra attualizzare Dt 15,4: «Che non vi siano dei poveri in mezzo a voi!».
L’ideale giubilare, in realtà, come non si realizzò per l’Antico Testamento così neanche per il Nuovo. Ci basti pensare all’episodio di Anania e Saffira che mentono per non mettere in comune i loro beni (At 5,1 -5). Come vivere le richieste dell’anno di grazia? Nel prendere atto che si tratta di un ideale da realizzare in continuazione, ricordare che senza ideali non si vive. L’ideale suscita energie e pone in cammino verso la meta individuata. L’ideale si realizza, allora, convertendosi, o in termini pasquali paolini, imparando a morire e risorgere a vita nuova ogni giorno!
PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Rabbi Eliezer diceva: «“Pentiti un giorno prima della tua morte”. I suoi discepoli gli risposero: “Chi conosce il giorno della sua morte?”. “Una ragione di più, dunque, di pentirsi ogni giorno, perché potresti anche morire domani... e così tutta la vita va passata nella “teshuvah” (conversione)».
L’insegnamento di questo rabbino, va confrontato con la riflessione di questo articolo e alla luce dell’insegnamento del nostro Fondatore (ad es. DF: «far morire l’uomo vecchio e far vivere in noi Gesù Cristo», preambolo n.9): che cosa ti suggerisce?
Suor Filippa Castronovo, fsp |